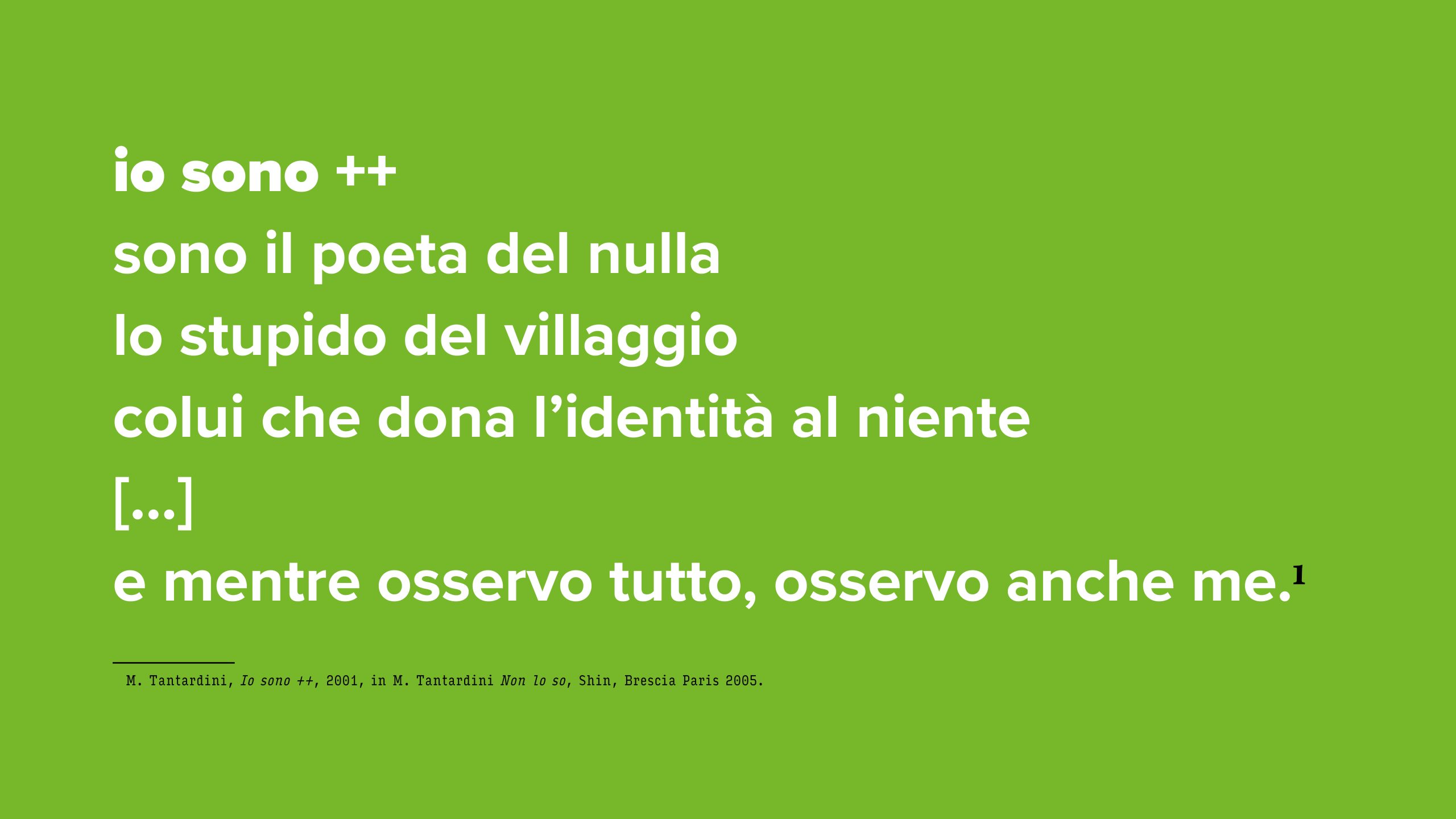Pare che le persone sperimentino una nuova relazione – al momento indefinita, quindi dinamica, cioè instabile – con l’ambiente. Lo spazio si presenta come un presentimento che talvolta ricorda una sorta di periodo ipotetico. La dimensione delle digital humanities riguarda la cultura in senso globale, la quale si trova (ancora e per ora) sospesa in una condizione indefinita dove l’articolazione dei contatti io-altro è delegata al rapporto corpi-schermi.
Ho condiviso l’idea (e ancora ci ripenso) della “relazione interattiva” che unisce – come in una sorta di sinapsi uomo-macchina – diversi fenomeni correlati quando la sussistenza dell’uno è presente, implicita, in quella dell’altro, cioè non è contrapposta. Siamo abituati ad interagire con il digitale, a misurarci in modalità immediata con la tecnologia, anche in una sorta di a priori post-contemporaneo. È accettato che nell’umanesimo ci sia già la tecnologia e che la tecnologia sia ormai (forse dapprima) nell’umanesimo; non c’è un’esistenza umana contrapposta a quella tecnologica e questo suggerisce che la tecnologia ha cambiato non solo la socialità, ma anche l’essenza dell’umanità[1].
In questa soglia dove si percepisce un pericolo, un cambiamento, il mosaico della dimensione antropologico-civile collettiva potrebbe ricordare una specie di screenshot globale privo di una struttura referenziale e quindi paragonabile, nella sua rappresentazione, ad una provocazione astrattista, la quale non essendo «immagine-di[2]» potrebbe lasciare senza parole. Eccolo quel sentimento di “qualcosa che sta per accadere” avvertito come un pericolo[3].
In una simile condizione, supportata dalla presenza di altre forme di intelligenza, torna ad essere centrale il problema di stabilire che “cosa sia l’arte” oggi. Diviene prioritario ricordare che la dimensione emozionale è uno dei modi più efficaci per generare conoscenza, attraverso il processo dello stupore e della meraviglia. Mi è già capitato di affermare[4] che l’impressione percepita di fronte all’opera d’arte sia quella di dubitare che essa stessa esista; di ritenere impossibile che quel fenomeno (che di fatto è già accaduto) stia accadendo (davvero).
L’aspetto sensazionale, l’opportunità straordinaria di lavorare a questo ambito della ricerca, fa riferimento ad un presupposto essenziale: sapere che qualsiasi ipotesi di scenario possibile provassimo a congetturare, molto probabilmente non potrebbe corrispondere alla realtà futura, quasi per definizione. Ho l’impressione che comunemente si cerchi di capire l’IA con la stessa prospettiva enigmatica con cui si guardava (e si guarda) all’intelletto attivo di Aristotele[5].
Probabilmente sarebbe meno efficace dal punto di vista percettivo se anziché chiamarsi intelligenza artificiale, tale «disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer[6]», fosse denominata memoria artificiale, algoritmo inferenziale o motore inferenziale.
Ecco, allora, l’urgenza di avviare un confronto in merito a cosa significhi creare, generare, progettare, rielaborare (quindi essere artisti, designer, umanisti, scienziati) in una sorta di post-contemporaneo dove l’intelligenza artificiale sembra rilanciare: memoria, intangibile, coscienza. Sono state create – o si sono generate – nuove categorie estetiche; dunque, quali funzioni progettare per poterle reggere?
Il tema è aperto, crossmediale, trasversale e tutto ciò è decisamente bellissimo e straordinariamente umano. Del resto, che cos’hanno in comune arti, scienze, filosofia? Indagano il mistero per offrire ipotesi di realtà. […]
Massimo Tantardini
(Direttore di «IO01 Umanesimo Tecnologico»)