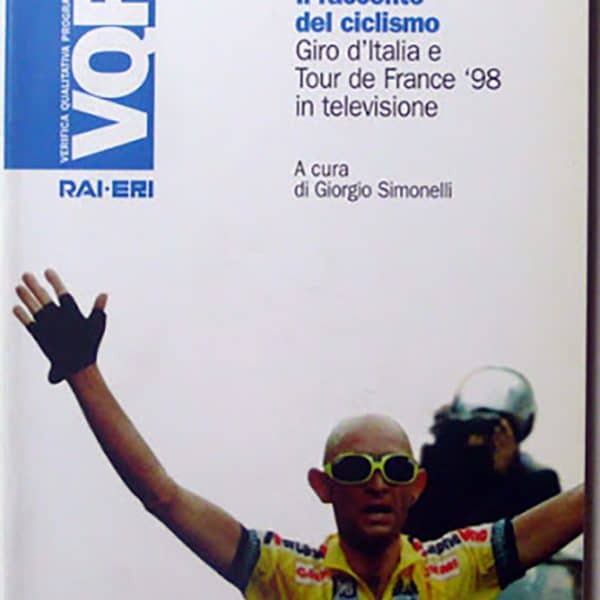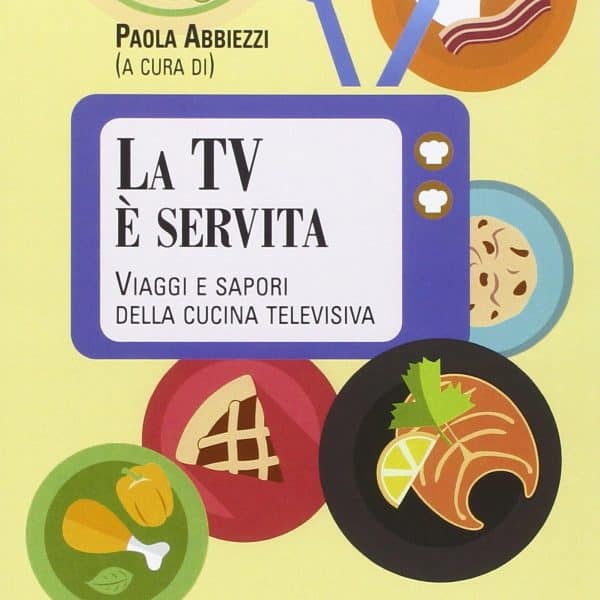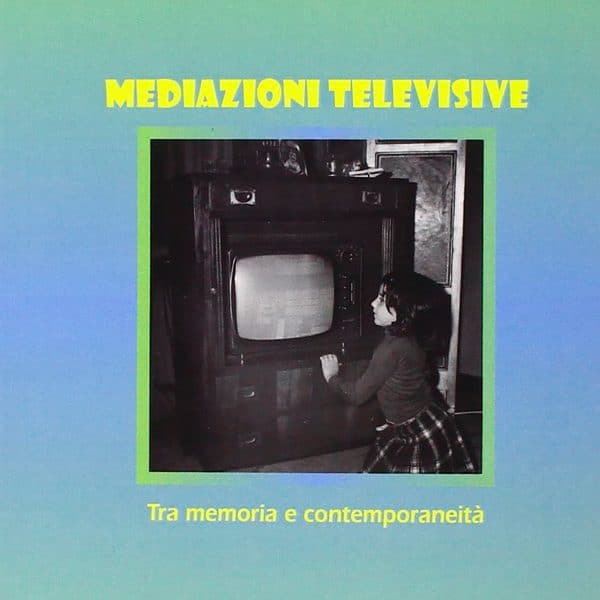Nell’era dei media, una delle condizioni piè; condivise, più globalizzate e, forse, più sottilmente democratiche, è quella dell’essere pubblico. Essere pubblico è oltre il guardare (attività già di per sé tutt’altro che neutra): il fruitore è parte della performance, dello show… del prodotto. In una dimensione che diventa, oggi, sempre più bifronte: sfrenatamente “personal” (secondo i miei tempi, i miei spazi, i miei gusti, i miei media) irriducibilmente “social” (…per poi commentare, per poi essere parte di, per poi mostrarsi come). La condizione dell’essere pubblico è allora tanto attività personalissima, quanto affare collettivo. La televisione, il mezzo di comunicazione in cui la relazione con il pubblico è più esplicitamente messa in gioco (e in discorso) non si è limitata a chiamare-a-sé il pubblico, ma lo ha, negli anni, abbondantemente rappresentato e raccontato. La pandemia, con l’evidentissima assenza di questa componente, ha allora sottolineato ciò che era già evidente: quanto questa rappresentazione fosse ormai parte integrante della drammaturgia. Ma ha forse, con il pubblico a casa, fatto altro, rinsaldando un rapporto, quello con il pubblico dall’altra parte dello schermo, che sembrava sempre più sfilacciato e problematico. Ne abbiamo parlato con Paola Abbiezzi, docente di Storia della Radio e della Televisione e di Giornalismo Radiotelevisivo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore didattico del Master Comunicare lo Sport presso lo stesso ateneo.
La pandemia ha messo in luce delle questioni riguardanti la rappresentazione del pubblico, o meglio la “non rappresentazione” del pubblico. Che cosa ha raccontato questa assenza?
Ha sottolineato il valore semiotico, significante, della presenza del pubblico: era sempre sembrato un “di più”, qualcosa che si rifaceva a un modello antico di televisione. Ricordo che gli studenti, quando analizzavamo questo aspetto, mi dicevano: “è un po’ cercare il pelo nell’uovo, sono cose da studiosi”. Invece ci siamo resi conto che la presenza del pubblico è parte integrante dell’aspetto significante del programma televisivo, sia per quanto riguarda i programmi di approfondimento informativo, che per quanto riguarda i programmi di intrattenimento.
Tu ti occupi di sport e la relazione tra lo sport e il pubblico è molto interessante: lo sport “non mediatizzato” veicola significati, narrazioni, che, quando lo sport è mediatizzato, vanno a sovrapporsi ad altre narrazioni, ad altri significati. Riusciresti a dare il quadro di questa complessità?
Lo sport vive di relazione con il pubblico nel suo realizzarsi: la presenza di un pubblico che incita, che partecipa, che critica, molto spesso condiziona la prestazione. Noi pensiamo sempre al calcio, ma pensiamo al valore nel tennis di questo pubblico, al valore del suo silenzio… che non significa assenza, ma va in contrasto, invece, con una parola detta in più, un rumore che distrae, eccetera. Un aspetto è quindi quello della relazione forte tra lo svolgersi della performance e la presenza del pubblico, che è parte integrante della performance. Questo prodotto viene poi mediato e quindi messo a disposizione di un pubblico più ampio. Lo sport è uno dei prodotti che mantengono quel valore cerimoniale della televisione che ha a che fare con il concetto dei media event di cui hanno parlato Dayan e Katz nei primi anni Novanta[1]. Questa dimensione fa sì che l’interazione del pubblico con l’evento sia più legata a una fruizione di un percorso narrativo: non ha un impatto sulla performance, ma ha certamente un impatto su quella che è la messa in scena dello spettacolo. Per certi versi ha anche condizionato alcune regole dello sport: i rigori per mettere fine alla partita di calcio, o il tie-break nel tennis e nella pallavolo, sono stati introdotti per rendere fruibile in televisione lo spettacolo sportivo. Uno spettacolo sportivo che si è sempre più adeguato a una narrazione che possa essere fruibile a un pubblico anche generalista. C’era stato un articolo dei Cahiers du Cinéma che teneva conto di tre tipologie di pubblico: gli appassionati dello sport (di quella disciplina), i disinteressati e gli appassionati di televisione. Come dire: a seconda del pubblico a cui ci si rivolge anche la messa in scena dello sport ha una sua tipologia di narrazione. Con la pandemia si è perso qualcosa: gli stadi erano vuoti, i palazzetti dello sport erano vuoti. Si è cercato, allora, di tornare a quella che è stata definita “l’essenza dello sport”, lo sport giocato. Ma ci siamo resi conto che questo sport giocato era monco. Hanno provato a compensare la mancanza di pubblico attraverso delle dimensioni virtualizzate, con stadi in cui si ricostruiscono i tifosi, in alcune situazioni (soprattutto all’estero) con le fotografie dei tifosi (“manda la tua foto”… e uno si vede inquadrato sugli spalti, attraverso il cartonato). Un tentativo di creare un coinvolgimento di partecipazione che di fatto non c’è. Una totale virtualizzazione, di cui già si era parlato anche con la presenza del pubblico, quell’avvicinarsi alla dimensione della “gamification”, della virtualizzazione dello sport attraverso i videogames. Il rischio un po’ è questo: che a mano a mano si perda il valore dello sport giocato.
Estendendo a tutti i prodotti di performance, una delle cose interessanti della situazione Covid è che la mancanza di pubblico permette sicuramente una maggiore concentrazione sulla performance stessa, ma genera un senso di horror vacui…
L’assenza di pubblico mette di fronte a una sorta di esperimento da laboratorio: può esserci una perfezione nella realizzazione e quindi, è vero, una massima concentrazione, però l’impressione è che manchi una variabile fondamentale. È quello che dicevamo all’inizio: la presenza del pubblico non è soltanto parte scenica di una dimensione in cui il cuore è la performance, ma sposta anche la messa in scena. È vero che, spesso, ci siamo detti: la narrazione ormai condiziona talmente la performance, che quasi si perde di vista la sua reale rappresentazione. Però ci rendiamo conto che quello che, forse, dà vita alla performance vera e propria, che ci dà quell’emozione, è proprio la relazione con il pubblico. Non dico che, perché il pubblico incita, uno può fare goal o non fare goal… ma prende vita.
La narrazione del pubblico nei media è cambiata enormemente negli anni. Si parte dalla gente di Soldati a Nanny Loy, al pubblico in studio come estensione del pubblico a casa, alla “gente” in stile Funari, arrivando ai reality e ai factual e, andando ancora oltre, alla logica del prosumer. Una «mutazione individualista»[2] verso il protagonismo. Eppure delle narrazioni permangono: il pubblico in studio, il pubblico sugli spalti… Come mai?
Secondo me il pubblico è alla ricerca di una relazione: anche con il consumo personale che avviene attraverso le piattaforme in streaming, vediamo il desiderio di condividere il commento rispetto a quello che si è visto. Si tratta di una partecipazione relazionale che si è spostata verso il legame e il riconoscimento in una community, che va a confermare quelle che sono le proprie passioni, i propri interessi; la famosa “bolla” sociale all’interno della quale uno continua a confermare le sue idee. Il consumo individualista non è solo isolamento rispetto al panorama mediale, esplode nella costruzione di una rete e nella ricerca di una comunità. C’è una necessità di riconoscimento identitario, che è quello che era un po’ alla base indefinita della televisione, dal pubblico monolitico (è per tutti e va bene per tutti) al pubblico di Telelombardia (per chi guardava le televisioni commerciali) al pubblico di Fininvest rappresentato in Drive in (giovane e un po’ paninaresco), eccetera. La dimensione e la presenza del pubblico va a consolidare la rete di community che si crea attorno ai prodotti. Dopo di che, nella televisione generalista ha un impatto di un certo tipo perché il pubblico è composto in maniera diversa, ma, secondo me, il tentativo di creare una relazione c’è anche in quel consumo individualista che è quello dello streaming, che, però, si sposta sui social, sulle reti di condivisione di altro tipo.
Parafrasando Contri[3] e sovvertendo la famosissima massima mcluhaniana potremmo dire che “la gente è il messaggio”: questa idea, che ha a che fare con la relazione col medium, ha anche a che fare con le modalità di rappresentazione? La gente è anche la narrazione, ora, o lo è in maniera più spiccata rispetto al passato?
Sì, o comunque è il risultato di una progressiva ricerca di raccontare la gente. Se noi pensiamo ai talk della metà degli anni Sessanta, ad esempio, a Renzo Arbore con la sua targettizzazione dei giovani (vedi Per voi giovani) abbiamo un’idea in cui, se io offro qualche cosa a te, faccio in modo che tu ti senta rappresentato e che la tua voce sia parte integrante del messaggio che voglio comunicare. Non credo che sia una novità di adesso: soprattutto dalla metà degli anni Sessanta si è cercato di integrare il destinatario all’interno del messaggio, poiché si era capito che il pubblico non semplicemente assorbiva quello che gli veniva detto, ma aveva una capacità relazionale che progressivamente si è evoluta.
Quindi, c’è qualcosa di nuovo nella rappresentazione del pubblico?
Faccio fatica a trovare qualcosa di veramente nuovo, faccio veramente molta fatica. Anche quando il pubblico diventa non il fruitore, ma il protagonista: anche il concorrente di Lascia o raddoppia rappresentava una persona comune che sapeva tutto di una cosa e quindi aveva delle qualità particolari; oggi, invece, il solo fatto di appartenere a una categoria, dà la possibilità di essere protagonista. Però, anche qui, forse qualche qualità bisogna averla, in fondo. Io, sinceramente, non vedo grandi innovazioni, grandi novità, o grande originalità.
Effettivamente, se si è tentato di inserire il pubblico “gente” fino alle estreme conseguenze, per cui il pubblico del reality in quanto persona, da un lato le formule successive stanno scansando questa modalità…
Non basta più. Perché quello vorrebbe dire collegarsi con la webcam su piazza Duomo, o sul caveau di una banca. Lì vedo esattamente quello che succede, ma non mi dice niente, perché manca la scrittura. È vero che la realtà si scrive da sé, ma il flusso indistinto della realtà non basta, bisogna metterla in discorso. E quindi la messa in discorso presuppone, comunque, una scelta, anche tra la gente, di un personaggio, persona comune che però ha un valore narrativo. La “finestra aperta sul mondo” degli anni Cinquanta, abbiamo capito che non è così, che non può essere così e che non ha nessun valore. Nemmeno oggi.
Quindi quella dell’acquario-reality, in cui metti persone normali che giocano o recitano a fare le persone normali, forse non era una novità neanche appena esplosa…
Forse non lo era neanche allora, però è vero che oggi ognuno ha la possibilità di farsi il suo acquario e di mostrarsi senza mediazione. Allora, io, laddove c’è la mediazione, mi aspetto che ci sia un valore in più, almeno che sia più divertente delle storie di Instagram… Quella cosa lì del Grande Fratello, sembrava una grande novità, ma ad oggi quella novità non basta più, abbiamo bisogno di una storia. E anche lì, comunque, il lavoro di scrittura veniva fatto a partire da un casting di un certo livello. Oggi, secondo me, la sensazione è che, se mediazione deve essere, deve avere anche valore, anche perché ci si è abituati alle “storie belle”, alla serialità, alla narrazione. Io non ho bisogno di riconoscere in un broadcaster così forte come è la televisione questo genere di contenuti. Forse la televisione ha recuperato quella dimensione cerimoniale, tant’è che durante il lockdown gli ascolti della televisione generalista sono aumentati: l’annuncio del lockdown del 9 marzo ha avuto uno share del 70% (22 milioni di spettatori), cosa da “paleotelevisione”[4]. Quello è un momento imperdibile e io, lì, lo guardo in televisione, perché quello è il valore della televisione. C’è stato un recupero del valore cerimoniale della televisione e della televisione generalista. Da che si diceva “la televisione non la guarda più nessuno” ci sono stati dei picchi di ascolto che hanno riportato alla televisione oltre 30 milioni di telespettatori. La pandemia, secondo me, ha dimostrato che è vero che posso trovare ovunque l’informazione, ma serve qualcuno in grado di mettere insieme il magma dell’informazione (con i limiti che la categoria giornalistica ha espresso). Il lockdown ha dimostrato che, nella necessità di fare ordine, chi può fare ordine è la televisione. L’appuntamento delle 18.00 per il bollettino della protezione civile era un momento imperdibile. Vuoi anche che, forse, nel “tempo sospeso”, si è ricercata una ritualità che consentiva di mantenersi “vivi”. Guarda caso, la ritualità è stata riportata dalla televisione. Con un appuntamento fisso che aveva degli ascolti molto alti. Poi, certo, quando si è ricominciato ad aprire, gli ascolti televisivi sono calati di nuovo, però nel momento di sospensione del tempo, il punto di riferimento è tornato a essere la televisione. È un dato che fa riflettere.
Tornando a quello che dicevamo all’inizio: questa sospensione poteva essere rappresentata, metaforicamente, anche dalla sospensione della presenza del pubblico?
Ha sottolineato la straordinarietà del momento. Uno di quei media event che interrompono il flusso, una situazione nella quale si diceva: “fermi tutti, perché questa è una cosa a cui prestare attenzione”. Il fatto anche che non ci fosse il pubblico rappresentato, il pubblico negli studi, anche questo sottolineava lo stato d’emergenza, e quindi ciò andava a sottolineare questa rottura con il flusso del quotidiano.
Prima, tirando molto la categoria, ho parlato di una serie di possibili rappresentazioni del pubblico: del pubblico “emanazione“, del pubblico a casa fino al pubblico protagonista. Ma quindi, esistono davvero molte rappresentazioni o esiste un’unica rappresentazione con qualche variante?
Secondo me la rappresentazione del pubblico è l’elemento di scrittura che sottolinea la relazione. Quindi laddove c’è rappresentazione del pubblico, si sottolinea la relazione. Nel momento in cui c’è il pubblico viene attivata la necessità di una relazione, quindi non è una cosa mia che faccio in un tempo mio, ma mi mette già in connessione con un tempo di altri. È vero che io posso guardare X Factor in un altro momento, però la presenza del pubblico (che si entusiasma, che partecipa e che batte le mani) mi fa capire, se lo guardo in un altro momento e non nel momento in cui c’è stato, che mi sono persa qualcosa. Ha a che fare con la dimensione della partecipazione. Non è tanto una modalità rappresentativa di una tipologia di pubblico, ma la costruzione di una relazione con il pubblico rispetto a quello che è un patto comunicativo che si va a costruire. Il pubblico dà valore nel tempo, dà la sensazione di “esserci”.