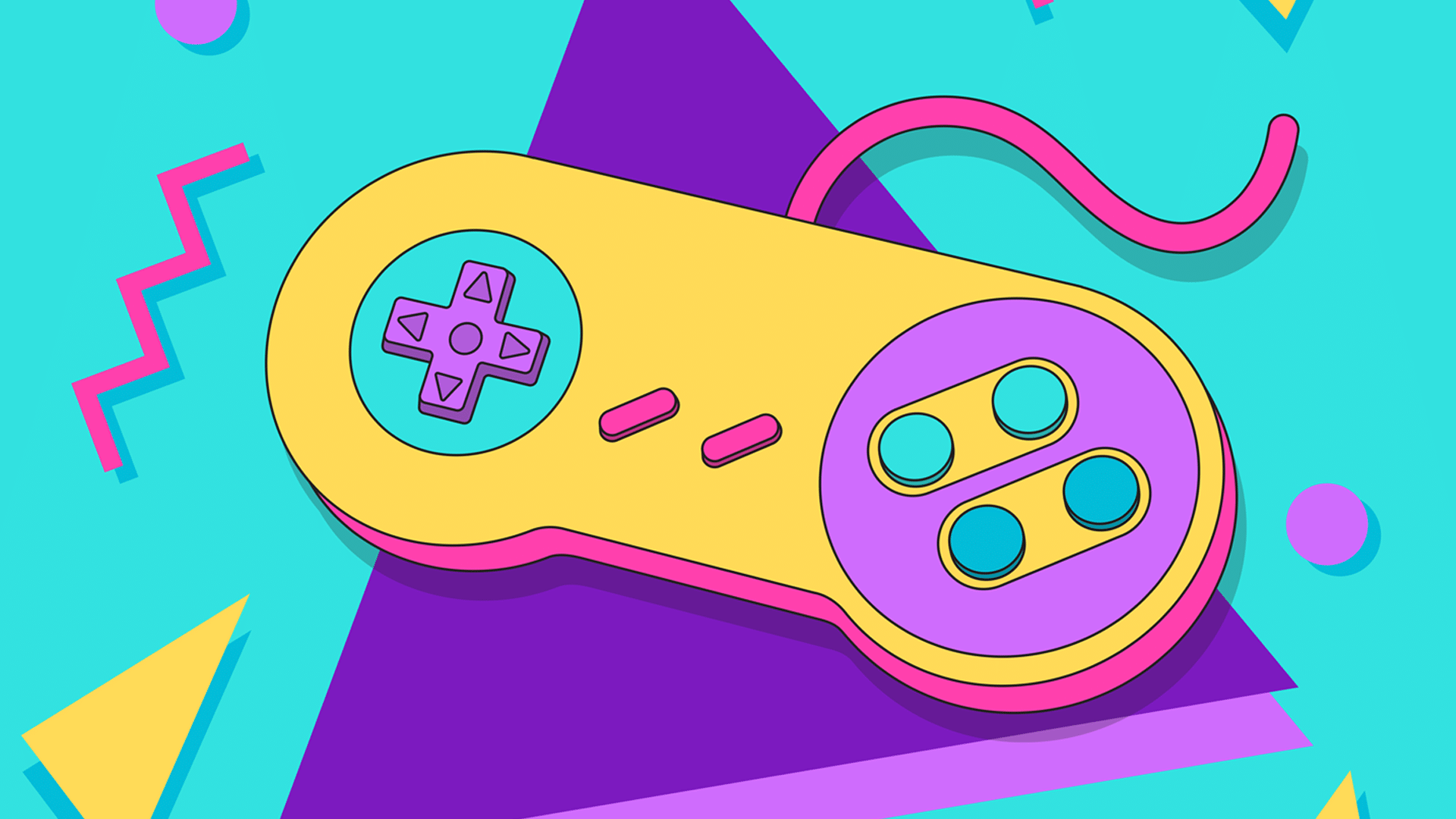Non mi piace il termine “virtuale”, che spesso viene usato nel linguaggio comune […] “Virtuale”, ci dice il dizionario, significa “ciò che è solo in potenza; potenziale”. Ma i soldi sono sul nostro conto corrente non solo in potenza. Sono assai reali. Solo che non sono materiali. Sono immateriali[1].
Come tutti gli eventi «epoch making»[2], la pandemia, oltre a (o più che) generare nuove dinamiche, ne ha messe in luce moltissime già ampiamente in corso. E in molti casi, la situazione emergenziale ha portato ad una rivalutazione, non di rado radicale, di molte di queste, sovvertendo giudizi (e pregiudizi) precedenti. Emblematica, da questo punto di vista, la posizione spesso ribaltata sulla tendenziale dematerializzazione in essere nelle società contemporanee avanzate, quella rinuncia progressiva (ma non assoluta) al tangibile che investe corpi, relazioni, azioni, interazioni… soldi (per rifarci alla citazione in esergo). Un ambito straordinariamente denso, in questo senso, è sicuramente quello del gioco digitalizzato, quello del videogioco o gaming; in questa sua forma ormai predominante, il gioco investe infatti ambiti apparentemente lontanissimi, tanto da portare al conio di un neologismo ad hoc: gamification[3].. La novità, rispetto al gioco analogico (ampiamente indagato da psicologi, sociologi, filosofi) sta nella capacità del gioco digitalizzato di chiamare in causa aspetti insospettabili, ma tipici della società contemporanea: dalla dialettica tra corpo e incorporeo all’idea di controllo, dalle pratiche narrative a quelle relazionali, passando per l’impatto sulla psiche. Un ambito, quest’ultimo, rivalutato in modo ufficiale dall’Oms nel 2020, ma già oggetto di studio e sperimentazione in precedenza. In Italia, in particolare, il settore di studio della cosiddetta Video Game Therapy è, non a caso, diventato un marchio registrato per opera dello psicologo e psicoterapeuta adleriano[4] Francesco Bocci, che ha costruito proprio un ambito di studi specifico attorno ad esso[5]. I presupposti riguardano lo straordinario valore evolutivo (oltre che sociale e, ovviamente, psicologico) del gaming, ma partono sempre da una valutazione del gioco in generale come luogo centrale nella costruzione dell’identità e nella sperimentazione del sé. Ed è proprio da questo punto che comincia la conversazione con il Dottor Bocci.
Anna Giunchi: Johan Huizinga affermava che «il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, per quanto possa essere definito insufficientemente, presuppone in ogni modo convivenza umana, e gli animali non hanno aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare»[6]. Il gioco ha senso proprio perché libero da sovrastrutture?
Francesco Bocci: Il gioco rappresenta una leva evolutiva dell’individuo perché permette di scoprire la dimensione magica primaria di sperimentazione e di scoperta. È come se, attraverso il gioco, io riuscissi a “sentirmi” di più: proprio perché divento il padrone assoluto di me stesso, ho il totale controllo di me. Il bambino sperimenta, attraverso il gioco, la sensazione di essere, in quel momento, padrone di sé, quindi è libero, recupera una dimensione quasi magica, non illusoria, una dimensione, diciamo, dissociata dalla realtà e dalle restrizioni del reale. Il gioco diventa, come diceva Adler, una “lotta creativa”: mi scontro con la realtà, ma la ricreo. Nel gioco, il gaming rappresenta una leva evolutiva nella vita dell’individuo perché ha delle caratteristiche che permettono di imparare a stare al mondo. Una di queste è quella del sistema di regole: io prendo delle regole, le fisso entro dei confini e questo mi permette di entrare in contatto con l’altro, con un modo di comunicare diverso in base a chi ho di fronte. In questo modo il gioco permette di contenere in qualche modo quell’ “attivazione” tipica dell’individuo che, se non avesse un contenitore, un contenimento, una funzione della famosa «rêverie materna»[7], sarebbe estremamente confusa. Il gioco permette di creare, anche attraverso queste regole, dei significati a questa dimensione emotiva che emerge. L’altra caratteristica importante è che il gioco ha sempre una variabile esterna imprevedibile: io ho qualcosa di sicuro, di chiaro, e da lì devo fare i conti con qualcosa che non conosco, il che si traduce in scoperta, in sperimentazione. L’altra cosa, poi, è che il gioco è partecipazione: io gioco da solo, ma giocando da solo entro in relazione con altri. Inoltre il gioco è un’attività libera; come diceva Bernard Suits[8] il gioco è un’attività volontaria, ma non necessaria: io non produco niente giocando, se non emozioni, pensieri, decisioni; imparo delle regole, ma nessuno mi obbliga a impararle. E poi, si tratta di una realtà fittizia separata dal reale, che ricrea dei “come se”: lì posso separarmi da certe emozioni, certi vissuti, come nella realtà non sarebbe possibile fare.
AG: Come dicevi, il gaming contemporaneo è molto legato alla dimensione relazionale che si sviluppa nell’ambiente dematerializzato. Quanto i pregiudizi in merito al gaming derivano da una visione distorta a riguardo?
FB: Attorno al videogioco ruotano molti pregiudizi, intanto perché non produce: i videogame non producono soldi, se no si tratterebbe di gioco d’azzardo. In una società narcisistica, dove la prestazione è tutto, dove, soprattutto prima del Covid (ma anche adesso) si punta solo al produrre, al fare, il gioco è una perdita di tempo. E qui il problema risale ad una cultura che ci portiamo dietro da centinaia di anni. Il videogioco è, invece, un ambiente in cui sperimentare le relazioni, quindi io, in realtà, nel videogioco creo collegamenti con altre persone che giocano con me, che siano persone nella stessa stanza o persone, invece, in dimensioni dematerializzate, quindi giocare, anche in modo virtuale, crea la possibilità di sperimentare le relazioni, sempre all’interno dei ritmi di gioco. E le relazioni che si sperimentano nei videogiochi sono molto maggiori, molto più autentiche rispetto a quelle dei social.
AG: Oggi si parla di “dimensione narrativa”[9], ovvero la tendenza a “filtrare” ambiti disparati attraverso le pratiche narrative, appunto; parallelamente è stato coniato il termine “gamification” per definire la diffusa applicazione del gaming a contesti disparati. Si può ipotizzare che questi due fenomeni si relazionino?
FB: Siamo in una fase storica in cui, anche a causa della (o grazie alla) pandemia, stiamo tornando a una dimensione più legata all’immaginario, all’immaginifico. La narrazione parte da quello, dal creare immagini. Si avvicina anche ad una scoperta dell’intrapsichico[10], quindi anche in una dimensione che potremmo chiamare “spirituale laica”, meno razionale. Nelle religioni moderne, soprattutto nella nostra, di immaginario c’è poco; c’è più nelle religioni antiche e anche nella cristianità. Mi viene da dire che c’è tutta una riscoperta di questo tipo. Il videogioco, essendo un gioco, va oltre il potenziamento e l’allenamento di certe abilità cognitive, motorie e anche emotive e anche oltre il cosiddetto gameplay[11], ma cerca di mettere insieme questa parte più intrapsichica/immaginativa. Questo attraverso una tipologia di videogiochi che si chiamano sandbox[12] (come Minecraft[13], Animal Crossing[14] eccetera) oppure con i film interattivi, come le escape room, con storie interattive. Parliamo di contenuti che possono essere anche educativi (e lì arriva la gamification) i cosiddetti serious games: si apprende attraverso il gameplay (quindi anche sbagliando, per prove ed errori) ma il gameplay è “vestito” di narrazione, mentre nei giochi arcade[15] classici il gameplay è puro. Possiamo dire che ci sono due funzioni del gioco: una “contenitiva”, più legata al gameplay (legata al “fare” e al controllo di quello che sto facendo); una più “creativa”, legata alla narrazione pura e più compensatoria di certe emozioni (emozioni che non posso vivere nella mia vita o da cui, comunque, ho bisogno di liberarmi). Questi livelli di coscienza (razionale – cognitivo – più emozionale – immaginario, simbolico, inconscio –) emergono entrambi in certi tipi di videogiochi, perché c’è, sì, una parte di gameplay, ma anche una dimensione scenografica e narrativa potente. Dal mio punto di vista, essendo un clinico, nella Video Game Therapy, il videogioco usato a livello terapeutico non può essere solo un allenamento, ma deve essere anche una riattivazione di dinamiche inconsce a livello catartico, come nello psicodramma, nel disegno e via dicendo.
AG: Che cosa, nello specifico, la Video Game Therapy innesca che non innescano approcci più classici?
FB: È quello che succede nello psicodramma, e, ad esempio, è quello che non succede nel cinema: il cinema ti dà delle emozioni, è vero, ma sono quelle che ti vuole dare, tutta la parte del gameplay e del “contenimento” non c’è, vivi e basta. Nel videogioco porto la narrazione nel gameplay, come nello psicodramma. Con una piccola differenza: nello psicodramma io recito una parte abbastanza lineare… è vero che posso improvvisare, ma c’è un setting più rigido, come nel gioco analogico. Il videogioco invece è separato dalla realtà, entri proprio in un mondo “altro”, non materializzato e questa condizione amplifica la potenzialità catartica. Il gameplay, oltre a questo, ti rende padrone di te stesso: una parte della tua mente, l’emisfero sinistro (legato alla memoria di lavoro) si attiva; l’altra parte, più legata alle emozioni, all’amigdala e all’ipotalamo, si libera di certi schemi mentali e finzioni, connessi a un sentimento di inferiorità, di angoscia e di paura, che abbiamo tutti. Questo perché tu sei concentrato, quindi riprendi il controllo di quello che stai facendo. Si tratta di un fortissimo antidepressivo: è un po’ come se l’emisfero destro si liberasse, l’emisfero sinistro si attiva e questo mi fa sentire utile, onnipotente e in potere di portare a termine un obiettivo. Per esempio, se io faccio giocare un ragazzo a un gioco arcade o a degli enigmi, in cui deve concentrarsi su quello, e poi intanto lo faccio parlare per libere associazioni, viene fuori di tutto perché lui ha meno paura di esporsi, perché lì ha il controllo di sé. Si chiama “effetto flow”, cioè l’emergere di uno stato di benessere che permette di sentirsi liberi di esprimere contenuti a volte anche difficili da esprimere perché traumatici; questa condizione viene da un equilibrio tra le sfide che il gioco mi chiede e le competenze che io ho. Il flow è un concetto coniato dallo psicologo Mihály Csíkszentmihályi[16], un grandissimo psicoterapeuta che ha parlato del flusso di coscienza. Il flow ce l’hai nello sport, nel teatro, nella lettura (perché nella lettura sei tu che crei) e appunto, nel gaming. Se il gameplay è adatto a me (è importante non far giocare i bambini a giochi in cui il gameplay è troppo difficile e deve essere calibrato) allora creo flow.
AG: Questi presupposti possono aver portato ad una rivalutazione del gaming durante la pandemia?
FB: L’Oms due anni fa asseriva che la dipendenza da videogiochi fosse una sorta di male assoluto, dopo si è ricreduta. La dipendenza da videogioco esiste, ovviamente, ma come per tutte le cose (c’è anche la dipendenza da gelato, a questo punto…) quindi farne una patologia diventa un po’ eccessivo. Il tema dell’Oms è che ha capito che proprio durante la pandemia si rivivevano certe dimensioni che era impossibile vivere nel reale. Chiaramente questo ha accentuato il bisogno di sperimentare, di immaginare, di tornare a quell’emozione che prima era scoperta. Diciamolo, non è solo il Covid, è anche perché il mondo oggi è molto saturo, quindi è chiaro che ho bisogno di cercare dimensioni altre. Quando tutto è saturo non mi basta più andare a messa la domenica o a parlare col prete (che non esiste più) ma devo andare dallo psicologo, devo andare a cercare altro, fino ad arrivare ad una dimensione spirituale e narrativa diversa. Bisogna tornare indietro parecchio per ritrovare dei periodi storici così, in cui siamo all’inizio di una nuova fase e in cui il gioco entra nella vita. Lì sarà poi capire come la narrazione entra nel gameplay e io posso far entrare narrazioni anche importanti: ci sono videogiochi che parlano di lutto, ci sono videogiochi che parlano di coppia, c’è di tutto adesso e ci sarà sempre di più, perché poi ci sarà la realtà aumentata che prenderà il posto del VR [Virtual Reality, ndr.]… io penso che da qui a dieci anni il videogioco entrerà completamente nella vita. E c’è anche una riscoperta del gioco analogico, del tatto. Purtroppo nel videogioco, al di là del gamepad, questa dimensione si perde. Il corpo viene ricreato un po’ con la testa, però non è mai come toccare. Però è sempre gioco. E comunque va detto che, come business, il videogioco è secondo solo ai farmaci.
Anna Giunchi
(Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, Brescia)